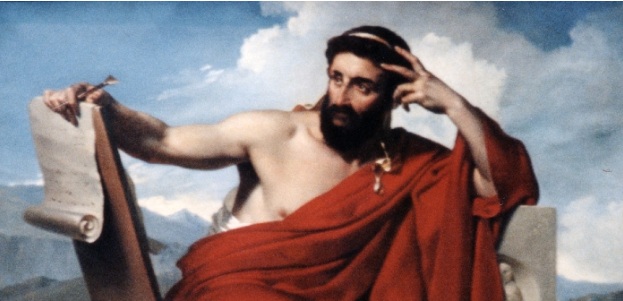Il
sonetto XII delle Rime di
Guido Cavalcanti è la cronaca di un'atroce esperienza in
limine mortis: visitando la
mente del poeta, la donna (o meglio: la sua immagine) vi semina un
tale disordine che egli maledice
la vista e invoca – troppo tardi – la cecità. Nelle due terzine
Amore, eccezionalmente chiamato in causa nelle vesti di dio pietoso,
cede il posto a Morte, che esibisce il cuore del poeta come
un macabro trofeo.
Paura,
tormenti, crudeltà, dolore, pianto e
pena: nessuno, oggi,
racconterebbe l'amore con queste parole.sabato 15 giugno 2013
venerdì 8 febbraio 2013
Le carte perdute di Solone
Heard melodies are sweet, but those unheard
are
sweeter.
- J. KEATS, Ode on a Grecian Urn
- J. KEATS, Ode on a Grecian Urn
Per la sua portata storica e per la ricca
messe di leggende che ha alimentato, la figura di Solone resta senza
eguali nell'età arcaica. Vissuto a cavallo tra il VII e il VI
secolo a.C., Solone è ricordato soprattutto come statista e
legislatore: nel 594 fu eletto arconte con il beneplacito dell'intera
popolazione ateniese e si prodigò nel tentativo di pacificare le
contese cittadine e di alleviare le sperequazioni sociali. Ma egli è
anche un gigante della poesia elegiaca del VI secolo, e i suoi pochi
frammenti sono sufficienti a illuminarne la grandezza.
Solone è un simbolo vivente della
Grecia arcaica: nella sua pratica di vita le due anime della
Grecità, quella politica e quella poetica, si compenetrano in
un'unità feconda e irripetibile. Quale delle due anime prevalga
in lui è impossibile da dire. Sarebbe quanto mai limitante
considerare Solone come un legislatore che traduce in versi la
propria concezione politica o come un poeta che ascende al potere
(l'etichetta che più gli si attaglia è, semmai, quella del
sapiente). Il margine di saldatura tra le due esperienze andrà
individuato in una straordinaria sensibilità umana, che le fonti gli
attribuiscono unanimemente (perché un'azione di governo degna di
rispetto muove dalla considerazione delle esigenze della
collettività), e soprattutto in una severa religiosità, unica
misura dell'intera sua opera.
sabato 13 ottobre 2012
La via del canto
di
lor canti i deserti, e l'armonia
vince
di mille secoli il silenzio.
Il
componimento che suggella il secondo libro dei Carmina di
Orazio, dedicato all'amico e protettore Mecenate, è il racconto di
una metamorfosi prodigiosa: il poeta si trasfigura in cigno,
preparandosi a un volo eterno che lo condurrà lontano dalla morte.
Traversando l'etere, vedrà gli abitanti del mondo conosciuto, dal
Bosforo all'Africa, dalle pianure leggendarie degli Iperborei alla
Colchide, dalla Dacia alle province di Iberia e Gallia. Nulla può la
morte contro la potenza del canto. Se la gloria poetica è un
possesso per sempre, il giorno dei funerali è giorno di giubilo.
giovedì 11 ottobre 2012
FANVM APOLLINIS
Putre
senescebat deserto in litore fanum...
- G. PASCOLI, Fanum Apollinis
 |
… clari
florebat lumine solis vividus...
|
Così Pascoli volle immaginare il declino
del paganesimo: gli dei, disertati i templi, vagano nel vento come
anime in pena; i ruscelli rimpiangono le ninfe; i Lari, spiriti
protettori del focolare, abbandonano borghi e crocicchi. Chi è
rimasto fedele all'antica religione vive nella penombra dei ricordi:
è il caso del sacerdote Actius, che nel suo tempio diroccato parla
ancora a una statua di Apollo adolescente.
Quando il prete cristiano Heron visita il
tempio per riconsacrarlo nel nome del vero Dio e i due sacerdoti
(l'uno pagano, l'altro cristiano) si scoprono compagni di scuola,
Actius supplica l'amico di risparmiare la statua e leva una preghiera
ad Apollo, sole di vita «che nasconde e svela il giorno, che nasce
sempre uguale e sempre diverso, che regna su tutto», «quello per
cui cantano le fresche fonti e i fiumi col loro mormorìo e il mare
col moto delle onde». Ma la la folla irrompe nel tempio, fa a pezzi statua e la getta in mare. «Le acque lo inghiottono e si richiudono, calme.» Mentre il vento risospinge gli dei
esiliati e i cristiani cantano un inno al loro Signore («tu diem qui restituis de nocte novum, tu, dux bone, Christe»), Actius sale su uno scoglio e contempla il tramonto del
sole. L'ultimo tramonto del dio che guida il carro.
Adesso il tempio non ha più un padrone: si regge in piedi a stento, come un relitto nelle tenebre; et tacitum lapsu percurrunt sidera caelum.
Adesso il tempio non ha più un padrone: si regge in piedi a stento, come un relitto nelle tenebre; et tacitum lapsu percurrunt sidera caelum.
Una lettura ideologica falsificherebbe il
significato del poemetto: al centro non è il conflitto tra
paganesimo e cristianesimo, ma la fede incorrotta di Actius, fatta di
memorie personali e di puro sentimento; è la storia esemplare d'un
pover'uomo inna-
morato della luce e della bellezza.
morato della luce e della bellezza.
Iscriviti a:
Post (Atom)